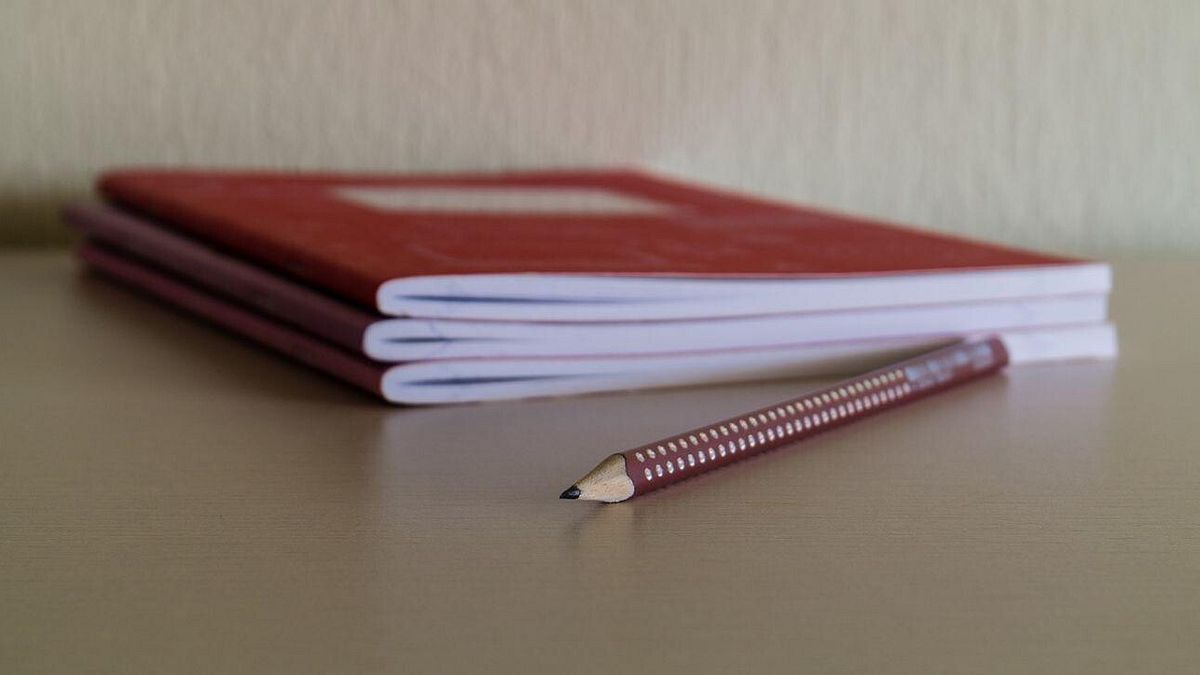Scuola, allarme suicidi tra gli insegnanti: quasi uno al mese
In Italia, nel decennio compreso tra il 2014 e il 2024 sono stati registrati 110 casi, con la media di quasi un decesso ogni trenta giorni
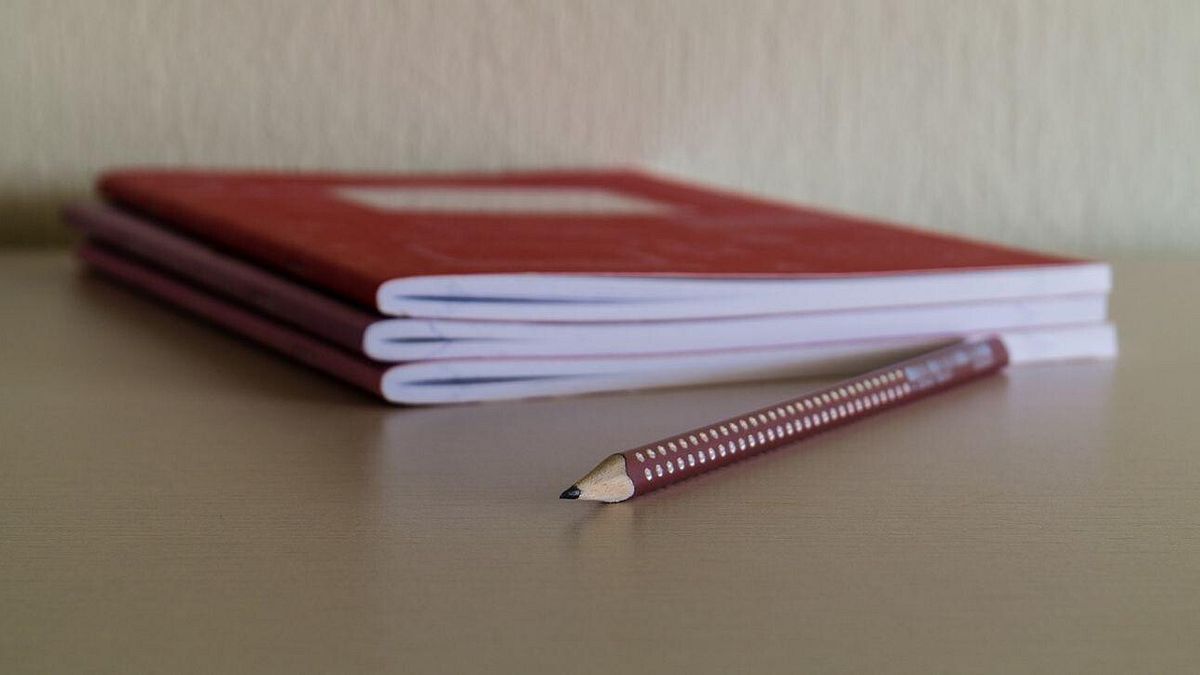
© web
Esiste un "costo umano" che spesso rimane nell’ombra quando si parla di scuola. Ed è quello che devono pagare gli insegnanti, che di fatto rientrano tra le categorie lavorative più sotto pressione. I docenti, infatti, figurano ai primi posti per numero di suicidi a causa dello stress da lavoro: tra il 2014 e il 2024, tra maestri e professori sono stati in ben 110 a togliersi la vita, una media di un suicidio al mese. Il trend rallenta solo nei mesi di luglio e agosto, guarda caso quando le lezioni sono di norma sospese. A riprova di quanto appena detto.
Numeri, questi, che peraltro potrebbero essere molto sottostimati. Mancano dei dati nazionali sui suicidi suddivisi per professione e, non di rado, questi decessi non vengono incasellati tra i suicidi. Eppure nessuno ne parla, a parte una recente indagine pubblicata LabParlamento - testata di approfondimento politico e sociale - di cui il portale specializzato Skuola.net ha messo in evidenza i passaggi principali, per accendere una luce su una realtà che da almeno un decennio continua a mietere vittime in silenzio.
Perché ogni anno, in media, si verificano da un minimo di 6 a un massimo di 11 casi di questo tipo di suicidi. Con un picco di addirittura 26 episodi segnalati nel 2017. Tra le tante cause c’è sicuramente quella del burnout, una condizione di stress che per i docenti si accentua di gran lunga nel contesto lavorativo e che certifica un dato su tutti: quello dell’insegnante è un mestiere usurante a livello psicologico, contrariamente a quanto si possa pensare.
Il "vuoto" legislativo
Nell’immaginario collettivo, infatti, il docente lavora poche ore alla settimana e può godere di ben tre mesi di ferie durante l’estate. La realtà, però, racconta una storia diversa: già la Francia nel 2005 e il Regno Unito nel 2009 e nel 2012 avevano dimostrato con statistiche concrete che la categoria fosse quella più esposta al rischio suicidario.
E pur non avendo studi ufficiali al riguardo - l’Istat segnala i casi di suicidio ma senza stratificarli per professione - anche in Italia è certo che parliamo di un mestiere tra i più ‘provanti’, con numeri che potrebbero essere addirittura falsati per difetto. Perché nessuno sa quanti siano realmente gli insegnanti che si tolgono la vita: non abbiamo infatti contezza dei dati relativi alle inabilità e alle malattie professionali degli insegnanti (che potrebbero spiegare l’alto tasso suicidario), semplicemente perché i dati delle commissioni mediche di verifica raccolti in 20 anni, ad oggi, non sono mai stati processati. Senza contare, poi, tutti i ‘tentati’ suicidi che non trovano spazio tra le pagine di giornale.
Eppure lo studio sul tema è abbastanza chiaro. Laddove non si arriva all’estremo ma alla semplice incompatibilità con l’insegnamento, nell’80% alla base ci sono diagnosi psichiatriche. Cinque volte più frequenti delle patologie vocali, come le disfonie, che pure sono tra le più comuni per chi lavora dietro la cattedra. Questo anche perché il decreto legislativo n°81 del 2008 - che dovrebbe, almeno in teoria, monitorare il rapporto tra stress e lavoro correlato per le professioni ad alto rischio (le cosiddette helping profession) come quella dei docenti - non viene di fatto applicato.
L’identikit dei docenti "suicidi"
Più nello specifico, l’età media del docente che decide di togliersi la vita è di 51 anni. E si abbassa a 48 calcolando solo gli insegnanti in servizio. Che, inoltre, si suicidano con una frequenza maggiore rispetto a quelli in pensione: 92 contro 18 nel decennio in esame.
Suddivisi per genere, parliamo di 45 uomini e 65 donne, nonostante queste ultime costituiscano l’83% del corpo docente. Quindi l’incidenza del fenomeno sugli uomini risulta molto più alta. Tuttavia, tra le donne va segnalato l’aumento dei suicidi in età da lavoro. Un dato che potrebbe fare capo a una questione prettamente biologica: non a caso l’età media delle vittime coincide, per le insegnanti, con il periodo perimenopausale, che espone a un più alto rischio depressivo.
E ancora, nonostante gli studiosi concordino nell’individuare un maggiore rischio dell'"usura psicofisica" nelle grandi realtà urbane, a dispetto dei contesti locali, la ripartizione geografica evidenzia una netta prevalenza delle morti violente al Sud e nelle Isole (58%), seguite dal Nord (23%) e dal Centro (19%). Al riguardo non c’è una spiegazione apparente anche se - specifica l’esperto - la ragione potrebbe stare nella diversa visibilità mediatica: nelle province del Sud un suicidio ha più probabilità di finire sui giornali rispetto a una grande città dove si perde nell’anonimato.
Quanto ai vari livelli d’insegnamento, invece, non sembrano esserci differenze significative. La frequenza dei suicidi è più netta alla primaria (23) e alla secondaria di I e II grado (rispettivamente 27 e 38 casi). Nella scuola dell’infanzia si registra, al contrario, un’incidenza inferiore, con 14 casi, che però è da imputare a un minor numero di docenti operativi e a un’età media molto più bassa rispetto ai gradi scolastici superiori.